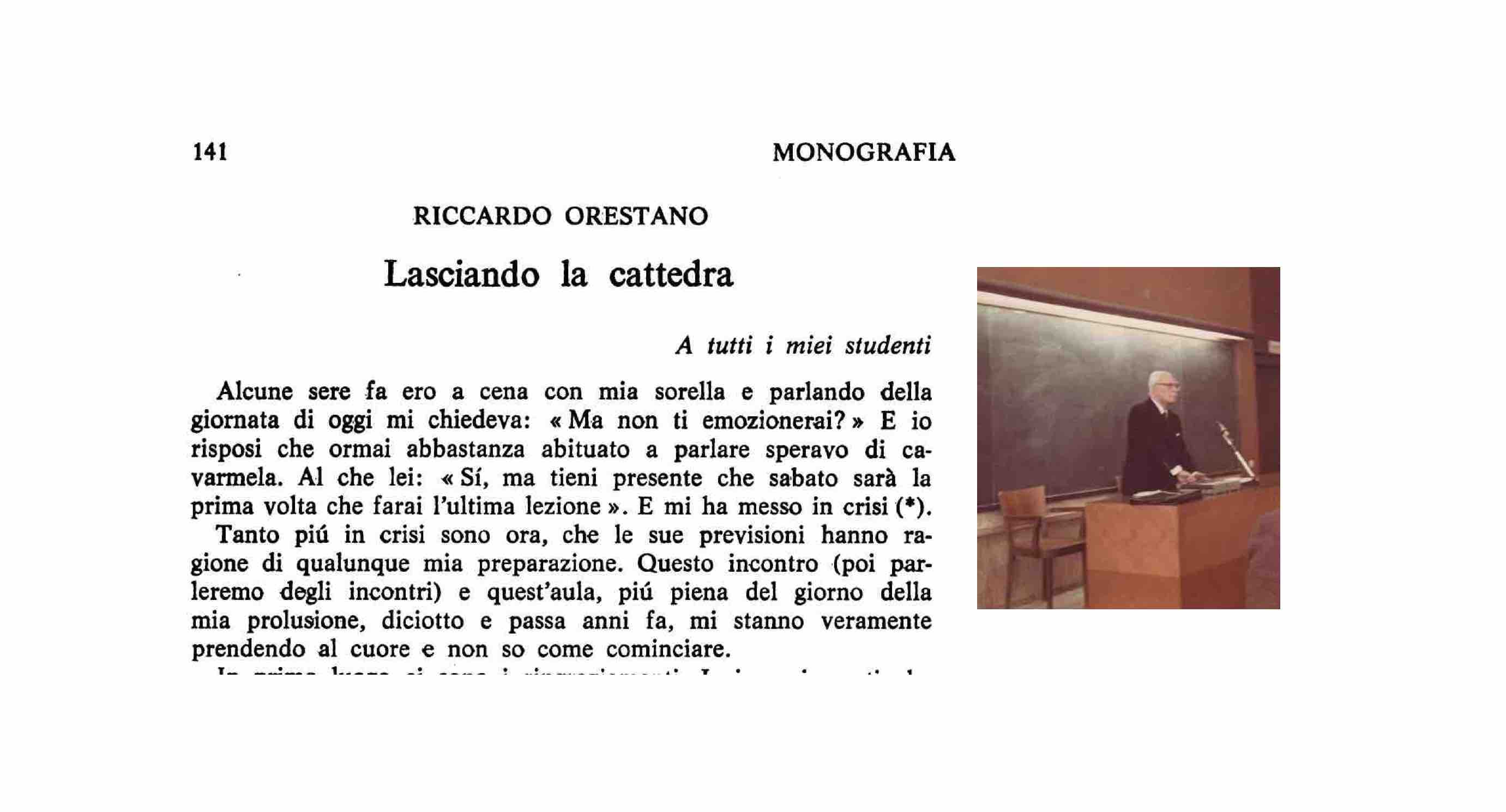Lasciando la cattedra, di Riccardo Orestano
Lasciando la cattedra, di Riccardo Orestano
(Il Foro Italiano, 1979, V, 141-150)
[Riccardo Orestano (1909-1988) è stato professore di Diritto romano alla Sapienza e Accademico dei Lincei. Il 19 maggio 1979 tenne la sua ultima lezione. Di seguito alcune considerazioni che in quell’occasione fece sulla dogmatica e sulla autonomia e libertà metodologica del giurista]
Sarà una delle mie colpe, ma, per quanto mi riguarda, mi sono trovato spesso costretto — come si suol dire — a rovesciare i termini delle questioni con cui ho avuto a che fare. Occupandomi di un qualsiasi argomento, il più delle volte mi è capitato, anche senza il proposito, di vederlo «dall’altra par te», di vederlo in un modo differente dall’usuale. Tanto per fare un esempio, se mi accade di pensare all’età arcaica di Roma, che tutti i modelli storiografici da secoli ci presentano come la ‘infanzia’ di quello che chiamiamo il diritto romano, essa mi appare invece un’età di estrema ‘vecchiezza’ di ancestrali tradizioni e di decrepite sedimentazioni, mentre le età successive, non come uno sviluppo, un’evoluzione, una crescita della più antica, ma una straordinaria rivoluzione, una lotta, un superamento, una creazione ex novo, contro di quella e in contrasto a quella.
Lo stesso è avvenuto nel mio progressivo allontanamento dalle forme dell’apprendimento e dell’insegnamento tradizionali, anche di quelle più legate ai tempi della mia formazione, e in opposizione alle quali son venuto conducendo una sorta di battaglia personale grado a grado più cosciente, che mi ha portato a vedere gli aspetti negativi di ogni forma di dommatismo, tanto più negativi gli aspetti quanto più raffinate e sofisticate le forme.
Dommatismo — per noi giuristi — significa anzitutto sistemazione o costruzione in ‘sistema’. Cioè qualcosa che ci dà l’illusorio e tranquillo possesso di una verità, anche se essa si riduce a mera tautologia. La gratificante sicurezza di trovare nel sistema e attraverso il sistema — magari con la sorpresa e la soddisfazione della ‘scoperta’ — una serie di conferme o addirittura la via per ‘soluzioni nuove’, dipende unicamente dal fatto che le une e le altre corrispondono, né più né meno, a quanto noi medesimi ci abbiamo messo dentro prima, nel “costruirlo”. È come definire il triangolo figura geometrica avente tre lati e poi compiacersi di scoprire che ha anche tre angoli, o viceversa, e che pertanto può essere soltanto retto, isoscele o scaleno. Si capisce quindi il costo che grava sul giurista quando si allontani da forme di dommatismo così appaganti, da tutte le forme di dommatismo, ancora tanto spesso seguite. Esse non sono senza significato rispetto al mondo contemporaneo e a quanto sottintendono, e che una volta di più io rifiuto.
Combattere il dommatismo significa una liberazione, ma significa pure portare il disordine, laddove regnava l’ordine. Non c’è niente infatti che appaia a prima vista più splendidamente ordinato e solido di una costruzione in sistema. È stata una delle maggiori aspirazioni delle generazioni che mi hanno preceduto. Tanto che, l’ho ricordato più volte agli studenti, uno dei rimpianti di Riccobono — vi insisteva negli ultimi anni — era di non essere mai arrivato a costruire nella sua lunga vita un’opera sistematica. Egli era stato allievo di Windscheid, e ai suoi occhi il fatto di non lasciare alcuna trattazione organica — perché se c’è produzione disorganica è quella di Riccobono — rappresentava una mancanza grave, imperdonabile, al punto di impedirgli di cogliere il valore dirompente del proprio apporto. Ed io già allora a dirgli: «Maestro, guardi che Lei ha fatto molto di più che costruire la sua opera in sistema; ci ha insegnato il senso della storia e la storia non si riduce a sistema, la storia non è sistema». Ma quando uno si libera dal “mito del sistema” — e Dio solo sa quanto mi è personalmente costato arrivarci, e farlo capire — non è che le cose si semplifichino. Al contrario.
Proprio allora tutto diventa più arduo, più difficile, più complicato. Occorre rivedere tutto, rimettere in discussione tutto e si finisce per avvertire come ogni cosa, oltre che animata e mobile, sia molto più sfaccettata, più articolata, più complessa, più composita, più piena di tensioni e di intime contraddizioni — in una parola, più problematica — di quanto non apparisse nelle forme statiche, riduttive, sclerotizzate degli schematismi e degli astrattismi cui certe tradizioni di pensiero ci avevano abituati e in cui ci eravamo cosi a lungo e dolcemente adagiati, accontentandoci gradatamente di piccoli “ritocchi interni”. La riconquista del concreto ci ha consentito di intendere che la realtà della vita e quindi della storia ha ben più corpo e sangue e dinamismo di quanto possa apparire dalle formule nelle quali abbiamo creduto di incapsularla e delle quali per tanto tempo ci siamo serviti e appagati, perdendo assai di sovente — così — il nostro rapporto di giuristi e il nostro rapporto di storici, con la vita e con la storia, pur tanto necessario a che il nostro operare serva appunto alla vita.
Ovviamente della vita e della storia non ci può essere rappresentazione che non sia concettuale, che non debba servirsi di concetti. Non è dato fare altrimenti. Ma da questo a pretendere di ridurre a tavole sinottiche la vita e la storia, ad acquietarsi agli astrattismi e alle formule, invece che anelare di continuo al contatto e alla verifica con i rapporti reali e con i problemi reali della vita, con il concreto della storia, cioè con quei rapporti, quelle situazioni in cui gli uomini sono impegnati con tutto il proprio essere — perché in definitiva si tratta della loro vita, della loro stessa vita, nella sua interezza — da questo ci corre molto. Indi il bisogno, pur tante volte proclamato ma cosi poco attuato, di ricondurre i concetti alla vita e non la vita ai concetti. Ma pure il pericolo, a non rendersi conto di ciò, di privilegiare i concetti sulla vita e di farne il fondamento della ‘scientificità’ della scienza giuridica, e fìnanco delle più varie prassi politiche.
…….
Qui lo dico orgogliosamente, mi sento — in quale misura non è questione — mi sento giurista. Parlo a nome mio, ma credo di poterlo dire per molti, esiste un orgoglio del giurista. Sarà un orgoglio non giustificato: lasciamo valutare altrui. Però il giurista è e deve essere ‘autonomo’, nel senso più proprio di questa espressione, cioè spetta a lui e solo a lui scegliere i procedimenti e determinare le regole del proprio operare. Ed egli può ben dire, dunque, «lasciatemi sbagliare da solo».
Guai se i giuristi si fossero piegati volta a volta a tutti i non giuristi che da secoli, coi propri ‘placet’ e ‘non placet’, hanno preteso di insegnare loro cosa fare e come farlo. I giuristi fanno come possono e quel che possono, sono secoli e millenni che fanno come possono, assumendone e vivendone essi ed essi soli la responsabilità piena.
Ovviamente con questo non intendo affermare che il risultato della loro opera sia da considerare sottratto a critiche. Anzi — proprio perché la loro opera finisce per incidere su tutti — ognuno può esercitare su di essa la più ampia facoltà, il più libero diritto di critica, dai filosofi più eccelsi al più sprovveduto degli uomini, dal ‘princeps’ all’ultimo dei ‘plebei’.
Meno ancora intendo dire che i giuristi non debbano tener conto delle critiche loro rivolte da qualunque parte vengano, e neppure che ciascun giurista — come ha fatto in ogni tempo — non possa liberamente attingere a qualunque fonte di pensiero e di vita, a qualunque sollecitazione gli venga dalla realtà concreta, dalla storia in cui vive e di cui è partecipe, com’è partecipe — lo voglia o no — degli ideali e delle ideologie del suo tempo, per adesione o per contrasto.
Poveri i giuristi che pretendessero di chiudersi e imbozzolarsi in se stessi. Ove taluno ci riuscisse avrebbe cessato di essere giurista.
Quel che rivendico è la libertà del giurista nel suo ‘fare’ e la sua libertà nello scegliere gli strumenti con cui farlo. Spetta unicamente alla sua sensibilità, alla sua responsabilità, e in definitiva alla sua coscienza, stabilire ciò che può servirgli ai fini che intende perseguire e i modi di procedere verso di essi.
È per questo che ritengo vadano rifiutate tutte le lezioni più o meno piene di sussiego che si è preteso per secoli, e ancor oggi, di impartire alla scienza del diritto dall’esterno.
Ed è per questo che, all’opposto, io sono stato e sono sempre disponibile ad accettare le lezioni di chiunque io riconosca giurista, dai miei compagni di lavoro e di strada, all’ultimo in ordine di tempo dei miei allievi e dei miei studenti, perché siamo tutti sulla stessa barca e tutti alla continua ricerca dei procedimenti e delle regole cui attenerci in questa nostra faticosa e contrastata navigazione.
Ma che qualcuno da terra, ma che qualcuno dall’aereo, pensi di pilotarci, dicendo: attenzione, devi fare questo, devi fare quest’altro, devi fare in questo modo o in quest’altro, ebbene io — ultimo dei giuristi — non l’ho mai accettato, non lo accetto e mi ribello in misura crescente verso chiunque, non giurista, abbia pretese del genere.
Lasciando la cattedra, di Riccardo Orestano
(Il Foro Italiano, 1979, V, 141-150)
 Loading...
Loading...