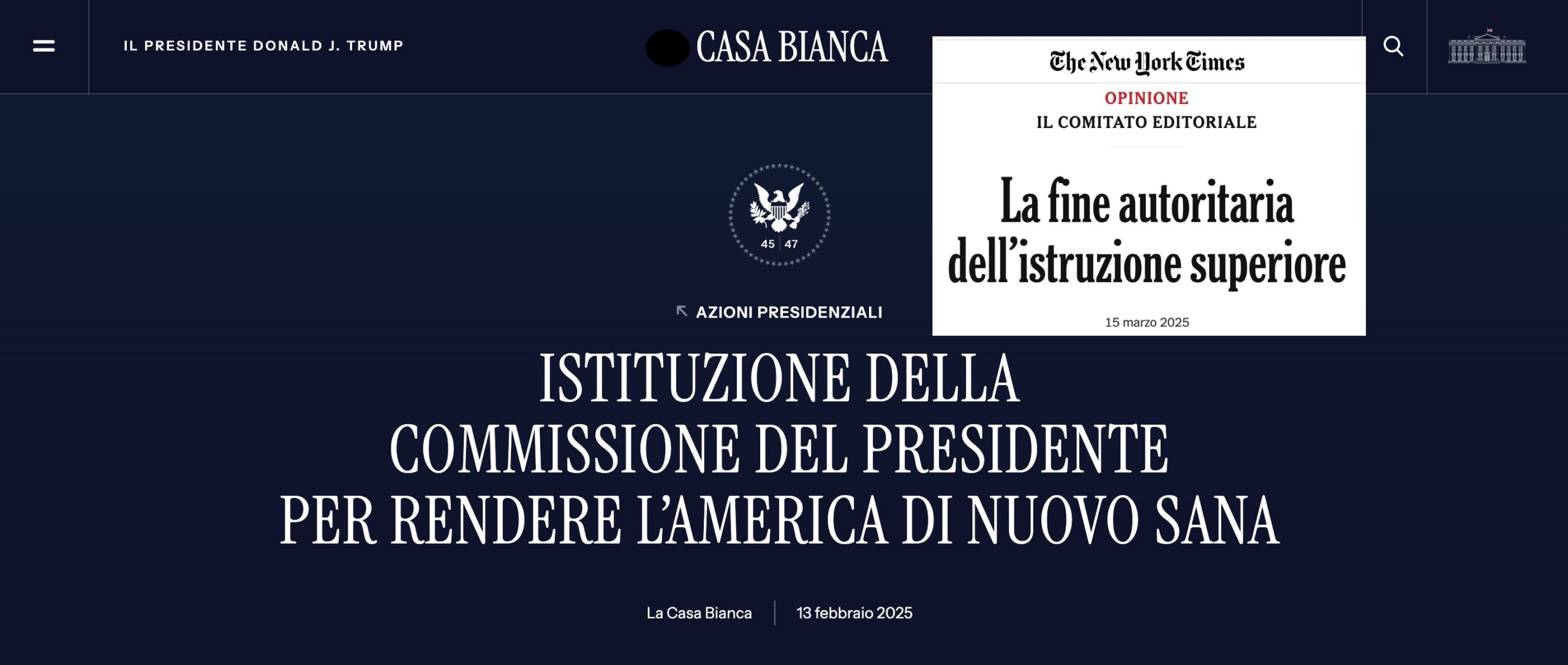Lo scorso 13 febbraio, Donald Trump ha istituito la «Commissione del Presidente per rendere l’America di nuovo sana» (“Make America Healthy Again”) (pdf_en; pdf_it). Partendo dalla constatazione che molti cittadini statunitensi soffrono di malattie croniche, Trump ha affidato a detta Commissione il compito di redigere, in pochi mesi, una strategia tesa a fronteggiare il problema specie con riferimento alle malattie croniche dei bambini.
Lo scorso 13 febbraio, Donald Trump ha istituito la «Commissione del Presidente per rendere l’America di nuovo sana» (“Make America Healthy Again”) (pdf_en; pdf_it). Partendo dalla constatazione che molti cittadini statunitensi soffrono di malattie croniche, Trump ha affidato a detta Commissione il compito di redigere, in pochi mesi, una strategia tesa a fronteggiare il problema specie con riferimento alle malattie croniche dei bambini.
L’iniziativa colpisce per due ragioni: a) la Commissione sarà formata da membri del governo e non, come sarebbe stato logico attendersi, da scienziati (al più potranno essere promosse audizioni di “esperti”); b) il documento guarda con sospetto ai contributi che vengono dal mondo scientifico visto che in esso si legge testualmente: «Dobbiamo ripristinare l’integrità del processo scientifico proteggendo le raccomandazioni degli esperti da influenze inappropriate e aumentando la trasparenza sui dati esistenti»; ovvero «tutta la ricerca sanitaria finanziata a livello federale dovrebbe dare potere agli americani attraverso la trasparenza e i dati “open source”, e dovrebbe evitare o eliminare i conflitti di interesse che alterano i risultati e perpetuano la sfiducia»; o, ancora, la strategia suggerita dalla Commissione dovrà «ripristinare l’integrità della scienza, anche eliminando l’indebita influenza dell’industria, divulgando i risultati e i dati di base nella misura massima consentita dalla legge applicabile e aumentando il rigore metodologico».
In altre parole, si sostiene che il processo scientifico non sarebbe rigoroso perché i ricercatori si farebbero influenzare da pressioni esterne (vedi industrie farmaceutiche) così da diffondere addirittura dati e conclusioni false.
Temi come l’integrità dei ricercatori, la lotta ai conflitti di interessi, la diffusione illimitata e aperta dei dati sono arcinoti a chi opera nel mondo della ricerca scientifica. In questo caso colpisce che il sospetto venga usato per delegittimare il sistema della ricerca.
Il 15 marzo il comitato editoriale del New York Times (pdf_en; pdf_it) (che ha il compito di fornire ai lettori del giornale una visione a lungo termine formata non dall’esperienza e dalla competenza di una persona, ma sostenuta da determinati valori istituzionali) ha pubblicato una presa di posizione dall’evocativo titolo: «La fine autoritaria dell’istruzione superiore». In estrema sintesi i membri di tale comitato sostengono che: (i) l’indebolimento delle Università è parte importante della strategia tesa costruire una democrazia autoritaria (strategia che comprende anche l’indebolimento dei media e dei giudici indipendenti); (ii) Trump sfrutta il fatto che molti americani non si fidano dell’istruzione superiore: le università d’élite appaiono come parchi giochi privilegiati per i giovani che cercano vantaggi solo per se stessi; (iii) il sistema di istruzione superiore americano, nonostante tutti i suoi difetti, è l’invidia del mondo e ora si trova ad affrontare una stretta finanziaria che minaccia i suoi numerosi punti di forza che avvantaggiano tutti gli americani; (iv) i leader dell’istruzione superiore americana sono stati in gran parte timidi e silenziosi di fronte all’assalto di Trump: sembrano sperare che, se tengono la testa bassa, la minaccia passerà, o almeno passerà dai loro campus.
Perché tanta sfiducia nella ricerca e come si esce da questa situazione?
Le Università (non solo negli Stati Uniti) devono contrastare in maniera aperta ogni deriva autoritaria (anche al proprio interno). Devono continuare (o tornare) ad essere il luogo del dibattito aperto e franco dove non ci sono posizioni intoccabili per definizione. Il risentimento contro le élite intellettuali nasce anche dal fatto che spesso i ricercatori si presentano come depositari di un sapere distaccato che diventa fonte di una superiorità che legittima a trattare con sufficienza chi quel sapere non possiede: il fatto che adesso il Ministro della Sanità degli USA sia una persona che mette in dubbio l’efficacia anche del vaccino contro il morbillo forse deriva dal fatto che durante il Covid non è stata fatta una comunicazione della scienza all’altezza del problema e in grado di farsi capire da tutti. La scienza deve essere aperta senza che sia Trump a chiederlo: apertura vuol dire, come si è detto, dibattito, vuol dire diffusione gratuita dei dati e dei risultati prodotti dalle ricerche finanziate con soldi pubblici, vuol dire denuncia ed eliminazione di ogni conflitto di interesse.
Le Università, e i ricercatori che operano nelle stesse, devono saper comunicare all’esterno l’importanza delle cose che fanno dimostrando di saper applicare a se stessi i principi che da sempre governano la libera scienza: l’umiltà, la ricerca della verità dei fatti, la messa in discussione di ogni teoria come premessa per garantire il progresso della conoscenza.
Se, per non perdere i finanziamenti del governo federale, le Università dovessero omologarsi alle richieste più o meno esplicite del potere finirebbero per dar corpo proprio all’accusa di non essere impermeabili alle pressioni esterne.
Documenti correlati
- La presidente della Columbia viene sostituita mentre Trump minaccia i finanziamenti dell’università. Katrina Armstrong lascia l’incarico una settimana dopo che l’università ha accettato una serie di richieste da parte della Casa Bianca, The New York Times, 28 marzo 2025. (Pdf)
- La Columbia accetta le richieste di Trump dopo la revoca dei fondi federali, The New York Times, 21 marzo 2025 (Pdf) [Nel complesso, il piano dell’amministrazione, pubblicato in una lettera non firmata di quattro pagine (pdf), rifletteva un sorprendente livello di deferenza nei confronti dell’amministrazione Trump da parte di una delle più importanti università di ricerca private].
- La Casa Bianca progetta di sospendere i 175 milioni di dollari per Penn a causa della politica sui transgender, The New York Times, 19 marzo 2025 (Pdf)
- Trump chiede importanti cambiamenti nelle regole disciplinari e di ammissione alla Columbia, The New York Times, 13 marzo 2025 (Pdf) —- Lettera dell’Amministrazione federale alla Columbia University (Pdf)
Post articolo
- Comitato editoriale del New York Times, Un manuale per affrontare il presidente Trump, 6 aprile 2025 (pdf)