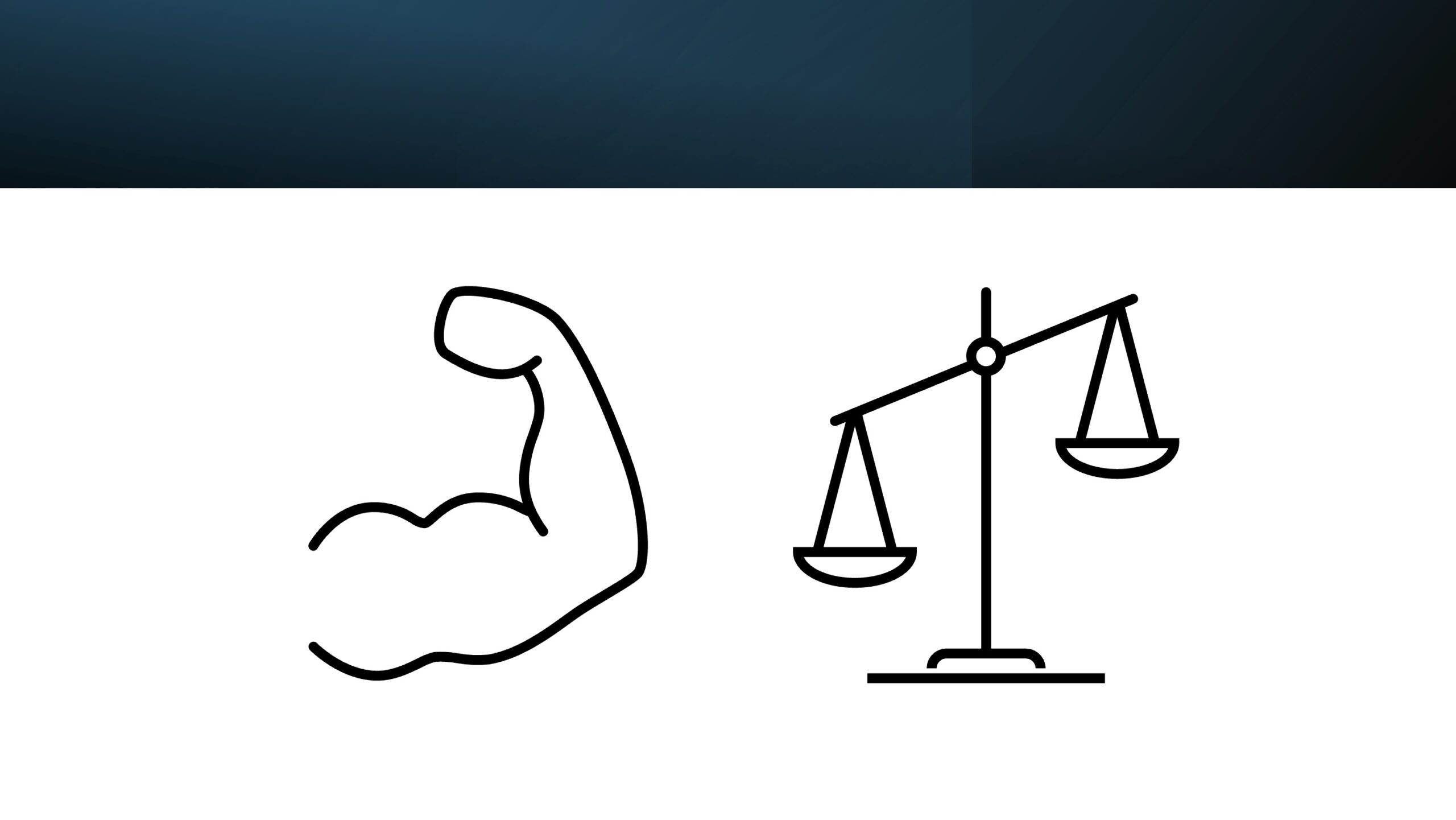Sempre più spesso sentiamo ripetere la frase “il diritto internazionale è morto”. Si usa per sottolineare che il diritto internazionale sarebbe inefficace perché non esiste qualcuno in grado di far rispettare le regole della comunità degli Stati (e di imporre almeno un cessate il fuoco nei tanti conflitti in corso sul pianeta).
Sempre più spesso sentiamo ripetere la frase “il diritto internazionale è morto”. Si usa per sottolineare che il diritto internazionale sarebbe inefficace perché non esiste qualcuno in grado di far rispettare le regole della comunità degli Stati (e di imporre almeno un cessate il fuoco nei tanti conflitti in corso sul pianeta).
Seguendo tale modo di ragionare anche il diritto penale o il diritto tributario dovrebbero essere quanto meno malati gravi se si considera l’alto numero di reati che rimangono impuniti ovvero la copiosa compagine di quanti evadono allegramente le tasse. Eppure, assistiamo al proliferare di leggi che introducono nuovi reati o inaspriscono le pene per reati già esistenti.
A ben vedere conclusioni come quella esposta nascono dell’idea che le norme giuridiche sono tali perché assistite da sanzioni: se non vengono osservate scattano punizioni di vario tipo (carcere, obblighi di risarcimento, sanzioni amministrative) ovvero si attivano meccanismi idonei ad attuarle in modo coattivo.
Ma il paradigma è davvero solo questo?
Quando onoriamo un contratto lo facciamo per paura di essere condannati all’adempimento coattivo e al risarcimento del danno oppure perché pensiamo sia doveroso rispettare la “parola data”? Quando evitiamo di occupare gli stalli destinati alla sosta delle persone con disabilità lo facciamo per paura di essere “multati” e di vedersi decurtati i punti dalla patente, oppure perché consapevoli che in questo modo contribuiamo a rendere un po’ meno gravosa la vita a chi non è in grado di percorrere in autonomia lunghe distanze per giungere nel posto dove desidera andare? Quando, in auto, teniamo la destra o ci fermiamo al segnale di stop lo facciamo per non incorrere nella sanzione amministrativa oppure per evitare il colossale ingorgo che si creerebbe se fosse lasciata ad ognuno la scelta di guidare come gli pare?
Nella sua concezione molto basica, il diritto ha una funzione essenzialmente repressiva dei comportamenti socialmente non desiderati. Di qui l’enfasi sulla sanzione e la convinzione che se non c’è la possibilità di applicare la forza bruta il diritto semplicemente non esiste.
Ma il diritto può svolgere anche una funzione promozionale: in questa diversa prospettiva l’ordinamento non mira a punire i comportamenti non voluti bensì ad incentivare i comportamenti desiderati.
Si possono fare numerosi esempi dei due diversi approcci: si può punire chi evade le tasse oppure si possono concedere benefici a chi le paga; si possono sanzionare i licenziamenti oppure si possono incentivare le assunzioni di lavoratori; e così via.
Ma lo scenario è ancora più complesso.
Le persone rispettano le norme per paura della sanzione oppure perché hanno fiducia nel fatto che anche gli altri lo fanno e che proprio la collaborazione reciproca permette di raggiungere i risultati desiderati e di governare la complessità del mondo? Per tornare ad un esempio fatto, quando guidiamo l’auto abbiamo fiducia nel fatto che anche gli altri rispetteranno le regole relative alla circolazione dei veicoli (per evitare il caos). In una trattativa contrattuale ci comportiamo secondo buona fede confidando che anche la controparte lo faccia: se si inizia una trattativa per porre fine ad una guerra ma allo stesso tempo si continua a bombardare è evidente che non ci sono le basi di un accordo perché si desidera solo imporre con la forza il proprio interesse.
Questo insistere sul fatto che il diritto esista solo se si è in grado di imporsi con la forza finisce con l’indurre a credere che il diritto coincida con la legge del più forte e che il diritto sia addirittura (im)posto dal più forte: così qualcuno è convinto che le cose gli appartengono solo perché ha la forza di prendersele.
Naturalmente occorre essere ben consapevoli del fatto che questa deriva esiste e che negli ultimi tempi sta conoscendo un inaspettato successo.
Ma si tratta di una concezione non molto evoluta del diritto.
Un diritto idoneo a governare società complesse non ha come motore principale l’uso della forza ma fa leva sulla capacità delle persone di cooperare per raggiungere obiettivi comuni di ampio respiro.
Alla base del diritto evoluto non c’è la forza, ma l’educazione che insegni a diventare cittadini in grado di assumersi le responsabilità che l’essere parte di una comunità comporta.
Il diritto di una società evoluta è uno strumento per promuovere valori e obiettivi condivisi facendo leva non sulla minaccia di sanzioni ma sulla capacità delle persone di cooperare avendo reciproca fiducia. Se così non è, semplicemente la società sta conoscendo un processo di regressione.